Foto: il CD Deutsche Grammophon
Ebbene, sì: sul nostro principe della musica, Giovanni Pierluigi di Sante, detto il Palestrina, è stata scritta anche un’opera lirica.
A misurarsi con l’arduo cimento, un compositore (tedesco, ma nato in Russia) di nome Hans Pfitzner (1869-1949), e il titolo del lavoro è – con ardito volo di fantasia – Palestrina.
La vicenda prende spunto da un aneddoto che tutti i musicisti conoscono, per averne sentito parlare nei corsi di storia della musica: il Concilio di Trento, nel reagire alla Riforma protestante, avrebbe avuto in animo di abolire completamente la polifonia liturgica, visto che Lutero aveva fatto del canto corale uno dei capisaldi della sua opera di contrasto alla Chiesa Cattolica.
Allo scopo di evitare questa sciagura, Palestrina avrebbe composto una Messa dalla musica così paradisiaca (e dovrebbe trattarsi della celebre Missa Papae Marcelli) che i Padri conciliari avrebbero dimesso il loro proposito.
Su questa trama Hans Pfitzner scrisse un libretto in tre atti che poi musicò e, essendo un post-wagneriano, ne fece un lavoro di dimensioni notevoli. Il sottotitolo è “leggenda musicale”, suppongo per sottolineare l’assunto non suffragato da prove dell’aneddoto stesso. La prima esecuzione dell’opera, composta tra il 1912 e il 1915, ebbe luogo a Monaco di Baviera il 12 giugno 1917 sotto la direzione d’orchestra di Bruno Walter.
Se la trama è esile occorre rimpolparla in qualche modo, ed ecco quindi fiorire una pletora di personaggi. Oltre al protagonista Palestrina, vi sono il Papa dell’epoca (Pio IV), numerosi cardinali, vescovi assortiti, il figlio di Palestrina, un suo allievo, e financo l’apparizione di Lucrezia, moglie defunta dello stesso polifonista. Nello scorrere il corposo elenco mi sono imbattuto in due nomi che mi hanno strappato un sorriso: il vescovo di Imola, che è la mia diocesi di appartenenza, e il Conte Luna, pressoché omonimo di un personaggio di ben altra fama, tra i protagonisti de Il Trovatore di Giuseppe Verdi.
La trama1 dell’opera
Atto I. 1563: si stanno concludendo i lavori del Concilio di Trento. In casa di Palestrina, a Roma, il giovane Silla è ansioso di partire per Firenze, verso gli orizzonti inesplorati del canto solistico, e non si sente più attratto dalle antiche polifonie. Mentre fa ascoltare a Ighino una sua composizione, entra Palestrina con il cardinale Borromeo: quest’ultimo deplora le note lascive che disonorano la casa dell’anziano musicista. Usciti i due giovani, supplica Palestrina di scrivere una messa, con cui testimoniare davanti ai padri conciliari la dignità artistica e spirituale del patrimonio polifonico, che molti di loro vorrebbero condannare alle fiamme. Palestrina però ricusa il contributo, con una fermezza che fa adirare Borromeo; rimasto solo, il compositore sfoga il suo dolore per la rottura dell’amicizia con il cardinale e deplora l’angosciosa solitudine cui l’uomo è condannato, l’inutile affannarsi che non produce alcun frutto. Intorno a lui risplendono però nove apparizioni, anime di antichi polifonisti venute a sollecitargli la creazione di un capolavoro con cui possa adempiere alla sua missione terrena; un coro di angeli suggerisce al vecchio maestro l’idea per la messa richiesta, e quando Silla e Ighino entrano nella stanza il mattino dopo, trovano Palestrina addormentato e lo scrittoio cosparso di fogli ormai completati.
Atto II. Trento. I cardinali discutono animatamente, gli uni decisi a chiudere celermente i lavori del Concilio, gli altri (soprattutto gli spagnoli, più intransigenti) altrettanto irremovibili nell’esigere l’esame rigoroso di tutti gli articoli. Morone apre la seduta, ma si vede ben presto costretto ad aggiornarla, visto l’inasprirsi dei contrasti fra i vari partiti; i servitori spagnoli si fanno incontro minacciosi a quelli italiani e tedeschi, per vendicare l’affronto patito dai loro padroni: nasce una rissa generale, drasticamente interrotta dall’arrivo del cardinale Madruscht, che ordina di sparare sui litiganti e di condurre i superstiti al patibolo.
Atto III. In casa di Palestrina. Il compositore è stato incarcerato da Borromeo, il giorno successivo il loro colloquio, per cercare di ottenere da lui, con la forza, ciò che non si era ottenuto con le preghiere. Mentre il maestro sonnecchia, i padri conciliari stanno ascoltando (così ci informa Ighino) la nuova creazione, da cui dipende il futuro della tradizione polifonica sacra; ben presto giungono i primi cantori a rendere omaggio al musicista, che si alza poi per ricevere il papa in persona, venuto a benedirlo. Piangendo, Borromeo invoca il perdono dell’amico ingiustamente angariato, ma questi lo abbraccia affettuosamente; l’opera si chiude sul quadretto di Palestrina seduto all’organo, immerso profondamente nei suoi pensieri, indifferente ai clamori osannanti che salgono dalla strada.
Ascolta l’opera nell’incisione del 1973 (Gedda, Fassbaender, Fisher-Dieskau, Prey, Chor des Bayerischen Rundfunks, Tölzer Knabenchor, Symphonie-Orchester des Bayerischen Runfuks, Rafael Kubelik direttore)
1.Trama tratta da Dizionario dell’Opera, a cura di Piero Gelli, caporedattori M. Mattarozzi e M. Porzio, Milano, Baldini & Castoldi, 1996.

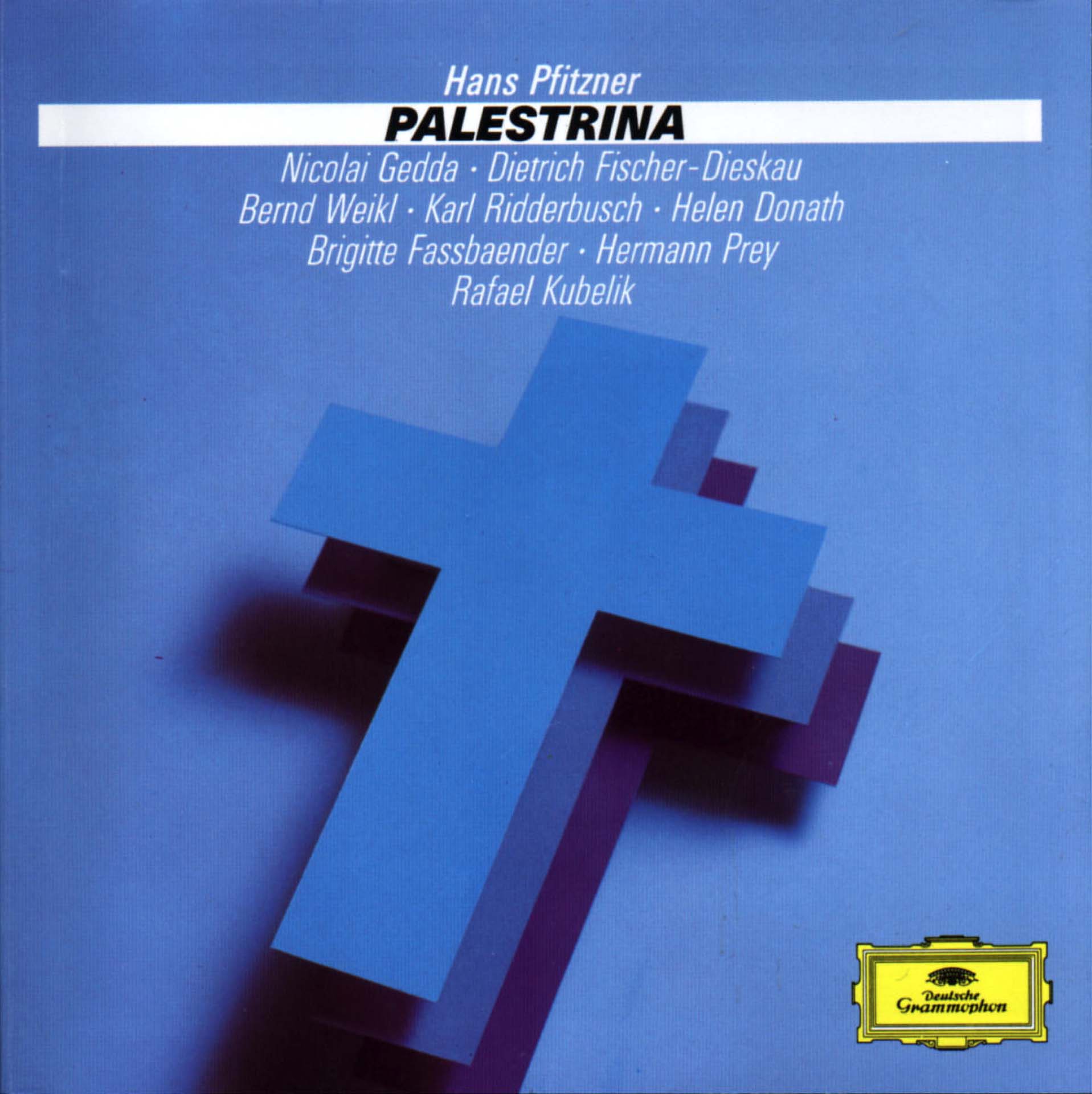


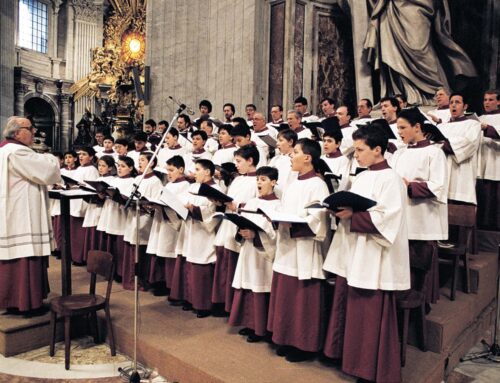
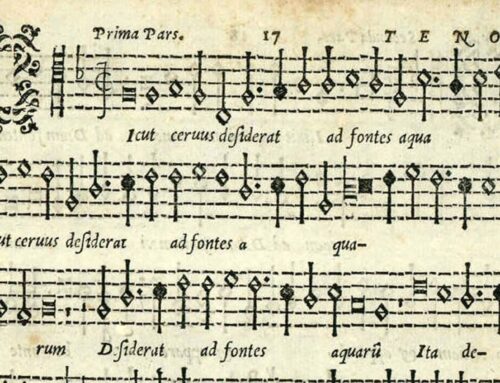



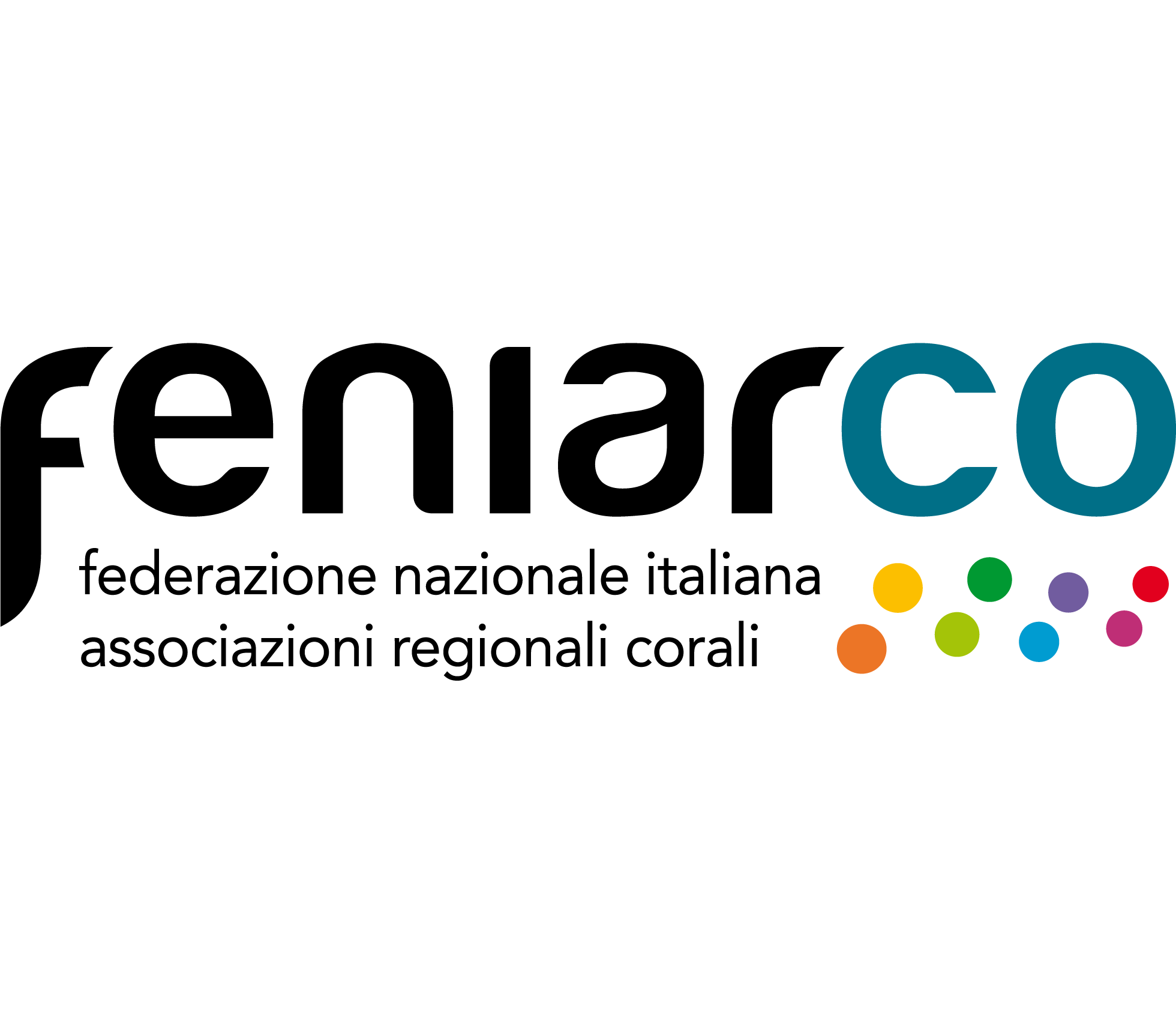
Scrivi un commento