Vita e opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina nel film Palestrina Princeps musicae di Georg Brintrup
Sulla vita e sulle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, tra i massimi compositori di musica sacra e profana del Cinquecento italiano, esiste una grande quantità di testi monografici e di raccolte delle sue composizioni musicali (la sua opera omnia fu pubblicata in venti volumi già a cavallo tra Cinque e Seicento), eppure soltanto il regista tedesco Georg Brintrup ha voluto dedicare al musicista italiano un film. Palestrina – Princeps musicae, girato nel territorio de L’Aquila poche settimane prima del terremoto del 2009, mira a ricomporre i frammenti di una narrazione lunga secoli e dare volto e corpo alle ragioni per cui Palestrina fu definito “principe della musica”, finendo per influenzare celebri compositori della propria epoca e delle epoche che sarebbero venute.
Palestrina è l’unico compositore rinascimentale di cui si sia tramandata ininterrottamente memoria. Lo si è sempre cantato, anche nel Settecento e nell’Ottocento, fatto che ha contribuito ad alimentare sul suo conto una vera e propria mitologia del tutto ignara del fatto che il XVI secolo era stato caratterizzato dall’attività di maestri molto diversi ma altrettanto grandi come l’inglese William Byrd o il fiammingo Orlando di Lasso che, come il film di Brintrup racconta, condivideva con Palestrina l’entusiasmo per le composizioni profane. Riprendendo la tradizione tradizione polifonica franco-fiamminga ma anche spagnola (Morales fu un esempio assai rilevante per il compositore), Palestrina selezionò con cura gli aspetti del linguaggio musicale del suo tempo che trovava più congeniali in una sintesi estremamente controllata e originale, evitando gli eccessi drammatici o la scrittura cromatica che sempre più connotavano l’opera dei suoi contemporanei. La sua concezione si potrebbe paragonare a quella del Petrarca che, nel suo stile di scrittura in volgare, seleziona soltanto un bagaglio lessicale molto specifico. Così Palestrina, anziché prendere tutti gli elementi possibili della musica del suo tempo, li seleziona e distilla, creando uno stile proprio dal carattere quasi metafisico, attraverso cui riesce a raggiungere vette di equilibrio e perfezione altissime.
Nel raccontarne la storia, Brintrup imposta la struttura narrativa del suo film sul montaggio alternato che intreccia una parte di mockumentary – le interviste fittizie ad amici e avversari del Palestrina, interpretati da attori che danno loro voce sullo schermo – ad una parte contemporanea che segue la giornata del maestro di cappella Flavio Colusso e del suo coro intento ad interpretare le opere del compositore rinascimentale sullo sfondo della Roma odierna. Il regista, in un certo senso, tenta di ricostruire in forma visiva una polifonia che restituisce la ricerca musicale dello stesso Palestrina. I contemporanei del maestro cinquecentesco sono portati in scena da volti di spicco come Remo Remotti che interpreta Filippo Neri, fondatore dei Padri dell’Oratorio; Renato Scarpa nella parte di Monsignor Cotta, segretario della Cappella Papale e antagonista del Palestrina; Giorgio Colangeli e Franco Nero rispettivamente nei panni di Leonardo Barré e Domenico Ferrabosco, ex-cantanti della Cappella Papale. Fa da collante alle vicende narrate il giovane Iginio, ultimogenito del Palestrina interpretato con efficacia da Domenico Galasso. Non manca la parte di ricostruzione storica che rende partecipe lo spettatore delle vicende di vita del Palestrina, talvolta turbolente e segnate da profondi cambiamenti, sia sul piano lavorativo e artistico sia sul piano personale.
La scelta di far parlare gli attori direttamente in macchina attraverso la forma dell’intervista in costume risulta un’idea interessante, ma la volontà del regista di avvicinare lo spettatore ai personaggi riesce tuttavia soltanto parzialmente, complice una fotografia senza chiaroscuri poco in grado di restituire le atmosfere rinascimentali che racconta. Inoltre, se nel 2009 le riprese video si confacevano agli standard televisivi dell’epoca, le stesse immagini riviste oggi non sembrano aver retto al passaggio del tempo, vittime del rapido avanzamento delle tecniche digitali al cui confronto la qualità visiva di questo lungometraggio risulta piuttosto obsoleta. Anche la scelta delle transizioni e della scomposizione visiva di alcune inquadrature, così come del ralenti e degli effetti visivi in 3D utilizzati per alcune sequenze, non sembra particolarmente efficace agli occhi dello spettatore contemporaneo.
Per le ambientazioni abitate dai personaggi, Georg Brintrup sceglie alcuni luoghi di cui Palestrina – Princeps musicae si fa testimonianza artistica. Ne sono un esempio due inquadrature che mostrano la Chiesa della Madonna del Lago a Santo Stefano di Sessanio (AQ) in due momenti vicini ma decisamente differenti: prima e dopo il terremoto de L’Aquila del 2009. Sfruttando i risultati delle scosse a scopi filmici, Brintrup decide di mettere in relazione il crollo dovuto al sisma con il tormento interiore di Palestrina e con i conflitti che imperversavano nella Roma del XVI secolo. In questo modo, oltre alla rappresentazione di momenti dimenticati della vita di Palestrina, il film è anche l’ultima documentazione visiva esistente di luoghi e opere d’arte aquilani perduti per sempre, come gli affreschi nel coro del Monastero della Beata Antonia e nella stanza quadrata del Palazzo Branconio.
Il regista tedesco sceglie di girare la parte del presente in bianco e nero, in contrapposizione alle interviste fittizie e alle ricostruzioni storiche messe in scena a colori. Il passato è dunque più vivido che mai, è presente visivamente più del presente stesso che mette invece in primo piano il suono e la ricchezza musicale delle opere che il coro interpreta. Così, nello svolgersi del lungometraggio, possiamo ascoltare le composizioni del Palestrina e apprezzarne l’espressione musicale ancor più della loro genesi storica che viene invece scarsamente indagata. Il film, infatti, per quanto godibile, da un lato presuppone già la conoscenza delle composizioni e di gran parte degli aspetti culturali del contesto in cui operò Palestrina, così da essere insufficiente a propositi divulgativi, dall’altro risulta carente per i suoi conoscitori a causa della presenza di banalizzazioni concettuali e di uno scarso grado di approfondimento. Rimane quindi ambigua la fisionomia del destinatario.
Non mancano poi alcune scelte musicologicamente discutibili. Nel film, ad esempio, viene riportato come veritiero il mito secondo cui l’esecuzione della Missa Papae Marcelli durante il Concilio di Trento avrebbe ‘salvato’ la musica polifonica dalla sua abolizione. La prima attestazione dell’avvenimento risale al 1607, vari anni dopo la morte di Palestrina, in uno scritto di Agostino Agazzari, ma tale vicenda si è rivelata tuttavia priva di fondatezza documentaria, come gli studi musicologici hanno oramai da tempo acclarato. Allo stesso modo, Palestrina – Princeps musicae insiste più volte sull’emancipazione del suono dalla parola, sostenendo che Palestrina abbia ‘liberato la musica’ dalla sua subordinazione al testo: un’affermazione altrettanto inesatta. Fin dal Duecento la scrittura polifonica aveva messo in primo piano la complessità di scrittura musicale, certe volte anche a discapito della comprensione testuale – al punto che Monteverdi ad esempio propugnerà la sua seconda prattica, incentrata sulla subordinazione della musica ai significati del testo, proprio in opposizione alla prima prattica dell’epoca precedente.
Nonostante queste imprecisioni storiche, una nota di merito va però ad una particolare accuratezza ricostruttiva: in una scena, è mostrato Palestrina al lavoro compositivo con l’ausilio di un liuto. Si tratta di una verità storica non scontata, dal momento che solo relativamente di recente gli studi musicologici hanno messo in luce questo aspetto della pratica compositiva.
Nell’approfondire la figura del Palestrina, il film riesce poi nel proposito di far conoscere al pubblico gli aspetti privati della sua vita, esplorando i conflitti intimi nascosti dietro alla sua grandezza artistica (le ambizioni musicali a cavallo tra sacro e profano, la connessione con Roma e con la corte papale, le complicate rivalità) così come con la fede (il percorso per il conferimento degli ordini sacri poi non perseguito). Le parole di Iginio sono il tramite per entrare nei nodi sentimentali e familiari della vita di suo padre: il grande amore per la prima moglie Lucrezia, sposata nel 1547 e scomparsa prematuramente dopo trentatré anni di matrimonio, il dolore per la perdita del fratello Silla e dei figli Ridolfo e Angelo, morti a causa dell’epidemia di peste tra il 1572 e il 1575; senza tralasciare una nota di ironia nel raccontare il suo attaccamento al denaro, forse alla base della rinuncia ai voti per convolare a nozze con la ricca vedova romana Virginia Dormoli. Il secondo matrimonio rivela infatti la sua costante ricerca di una tranquillità economica come via d’accesso verso una serenità esistenziale che la sola fama non sembrava potergli garantire. In questo modo, la figura dell’osannato “principe della musica”, che ancora oggi svetta nel centro della città di Palestrina con il profilo marmoreo scolpito dal fiorentino Arnaldo Zocchi, scende dal proprio piedistallo per acquisire una tridimensionalità e fragilità del tutto umane.
Scopri e guarda il film
Scheda del film
Italia, 2009, 52’, HD, colore
Produzione: Brintrup Filmproduktion / Lichtspiel Entertainment GmbH / ZDF / ARTE
Regia e montaggio:
Georg Brintrup
Sceneggiatura:
Georg Brintrup, Mario Di Desidero
Fotografia: Benny Hasenclever, Paolo Scarfò, Piergiorgio Mangiarotti, Oliver Kochs, Jorge Alvis
Interpreti: Domenico Galasso, Stefano Oppedisano, Claudio Marchione, Renato Scarpa, Achille Brugnini, Remo Remotti, Giorgio Colangeli, Pasquale di Filippo, Franco Nero, Daniele Giuliani, Bartolomeo Giusti, Patrizia Bellezza, Francesca Catenacci, Jobst Grapow
Direzione musicale: Flavio Colusso (direttore), Donatella Casa (direzione coro di voci bianche)
Cori: Ensemble Seicentonovecento, Cappella Musicale di San Giacomo, Coro di Voci bianche “J. J. Winckelmann”
di Lia Monguzzi fotografa e videomaker e Andrea Caciagli regista e giornalista culturale consulenza musicale di Alessio Romeo



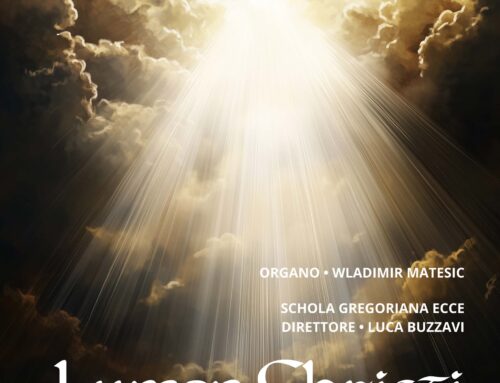



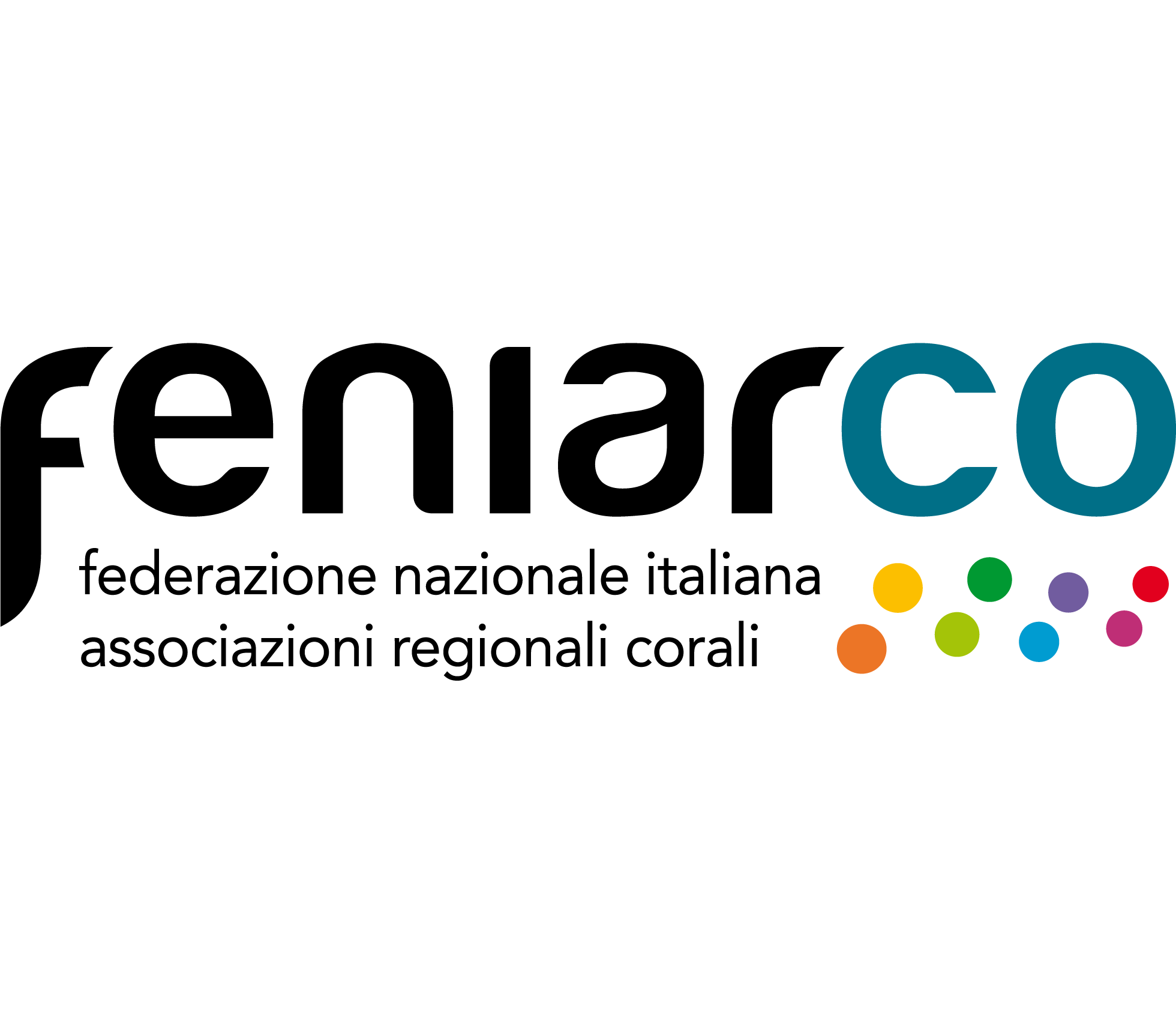
Scrivi un commento